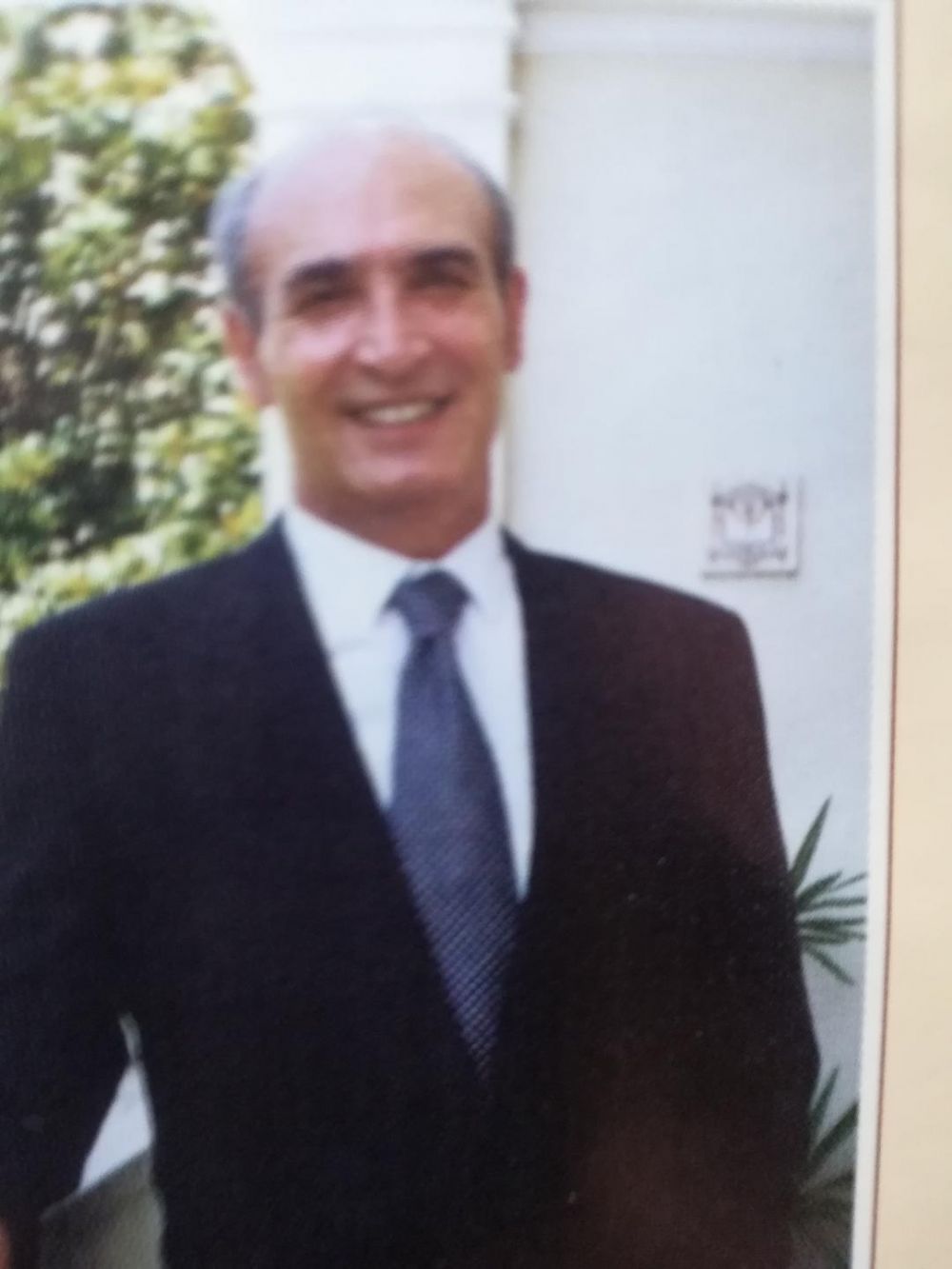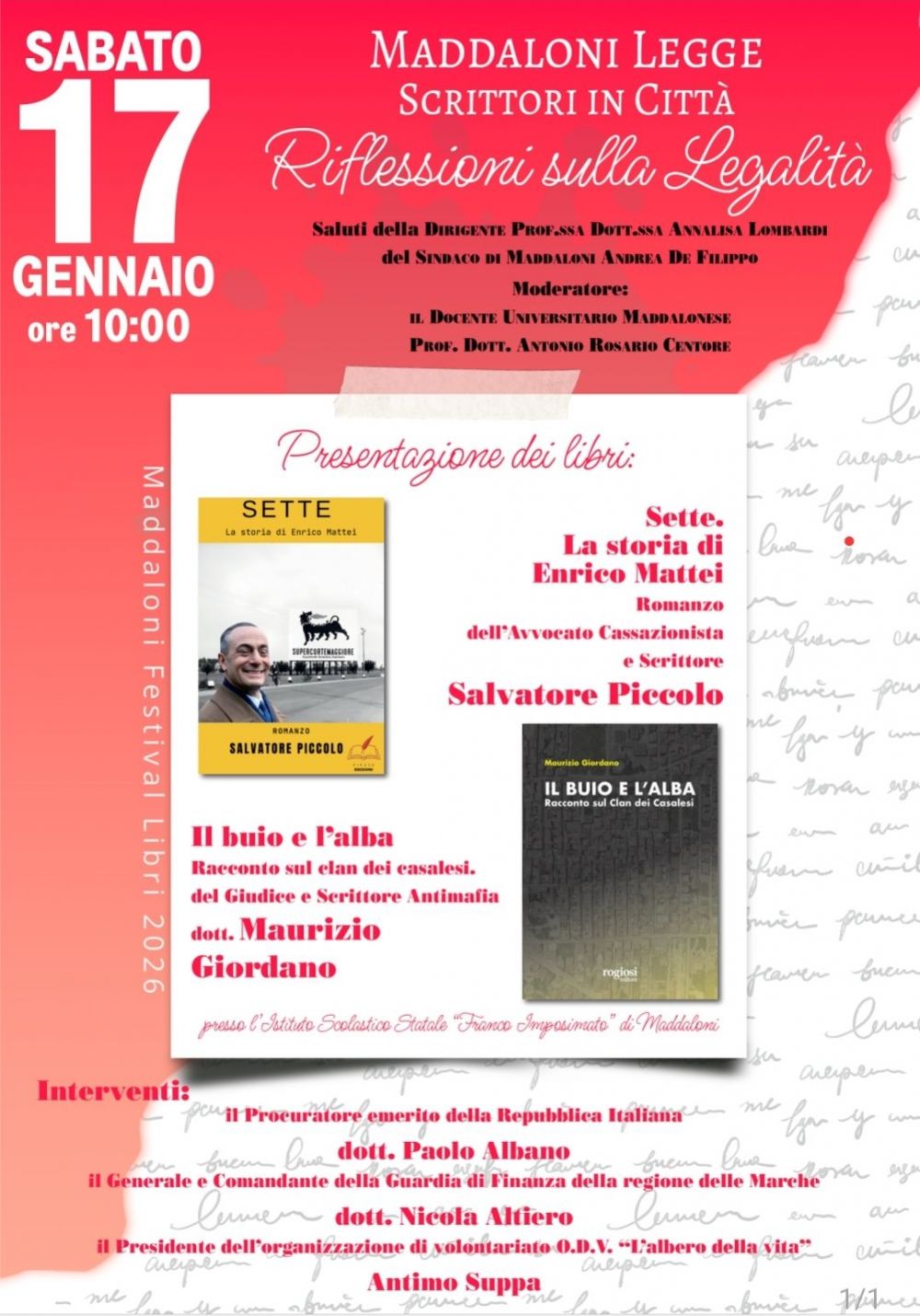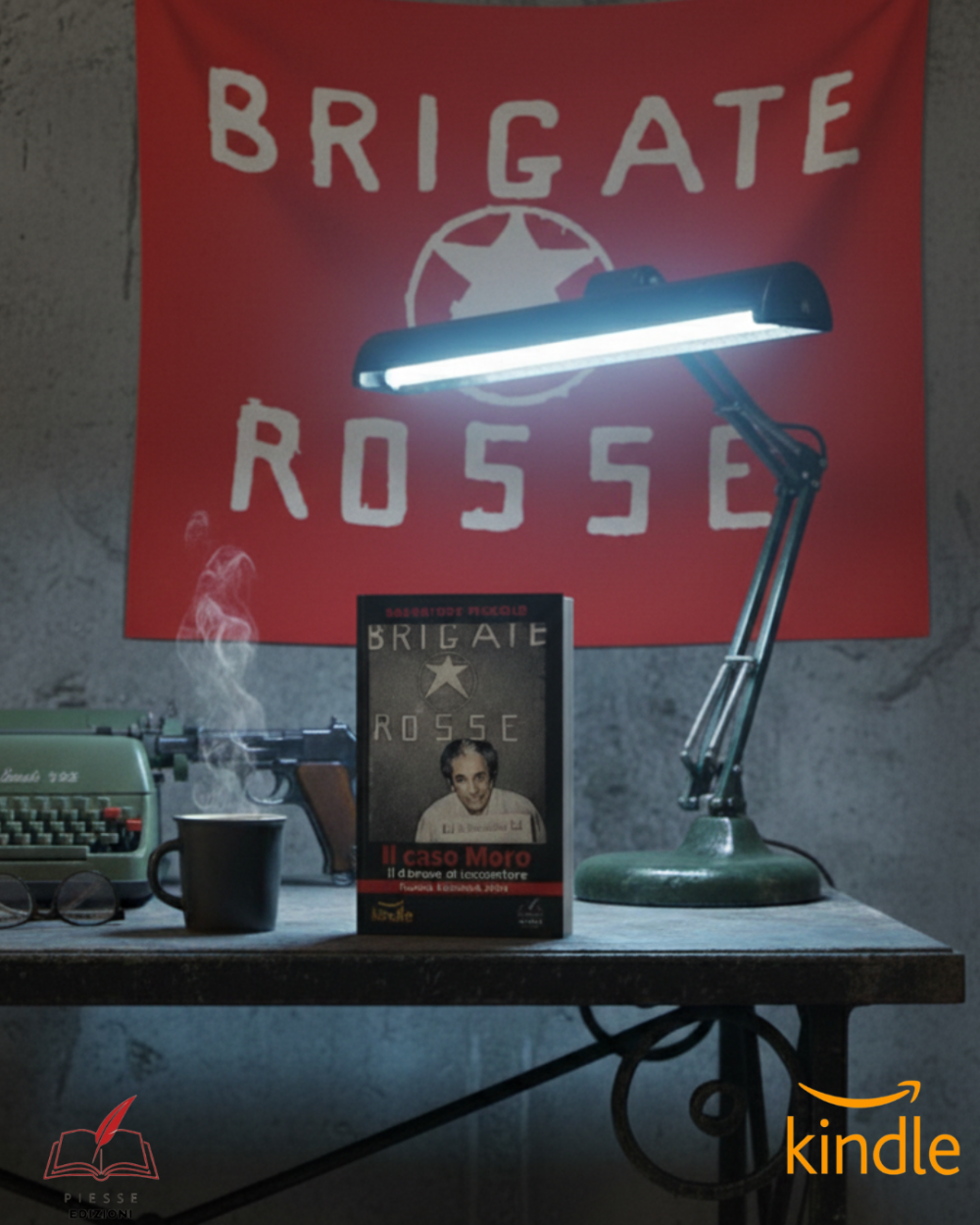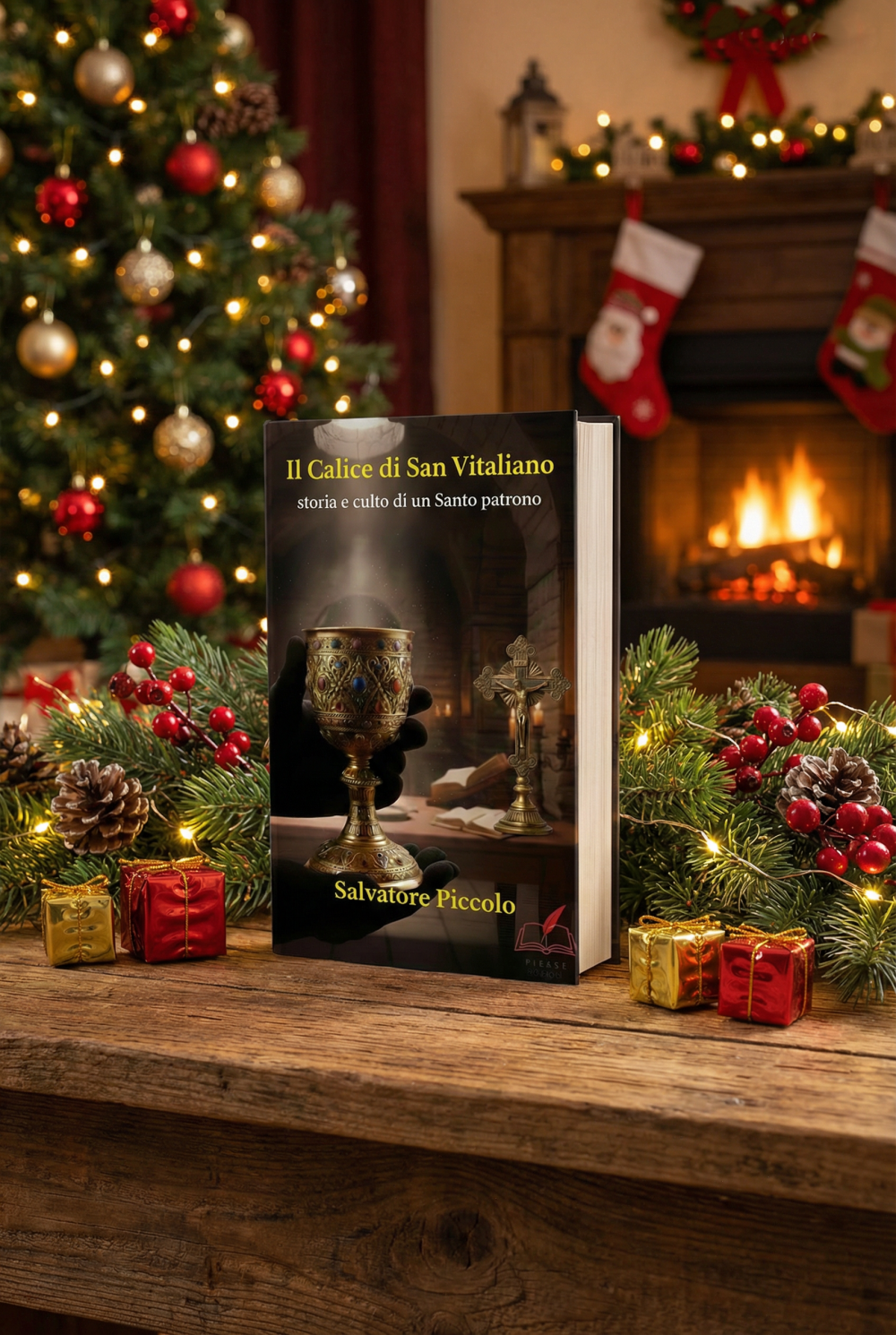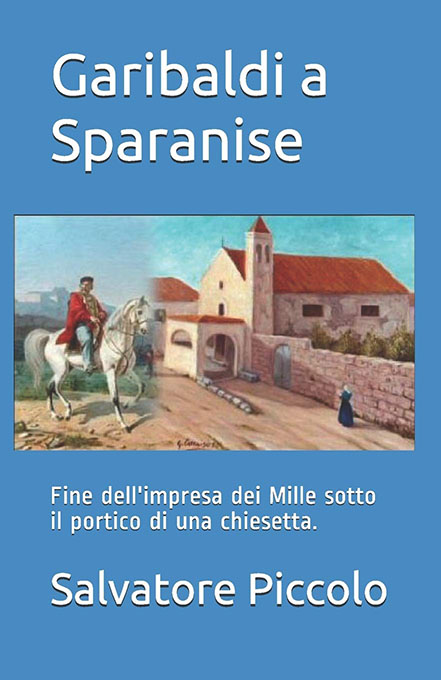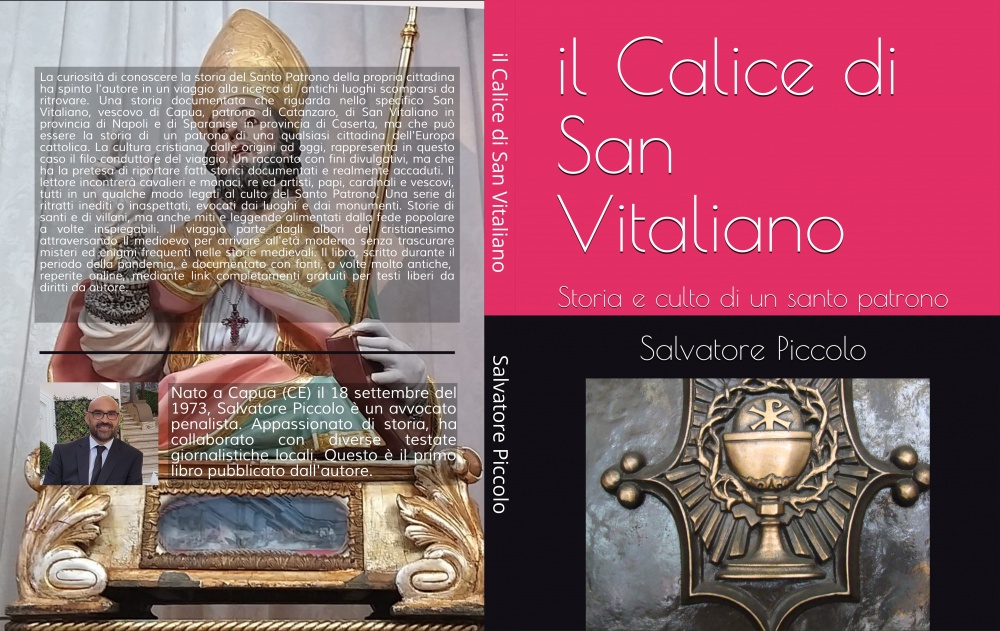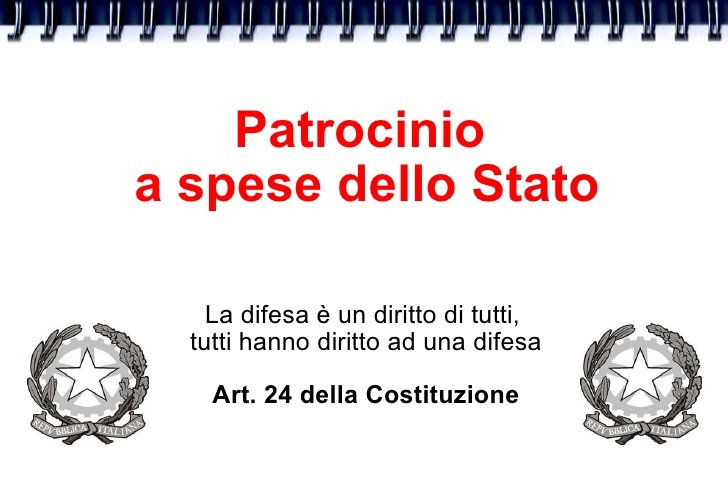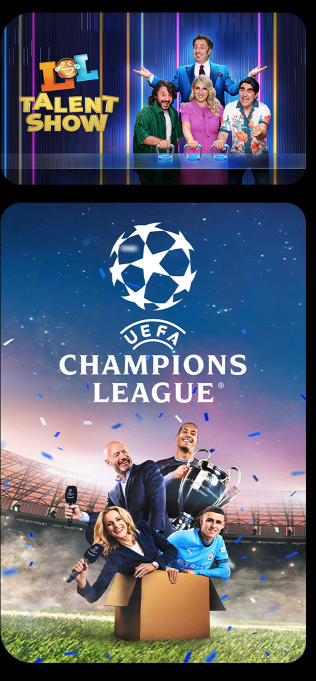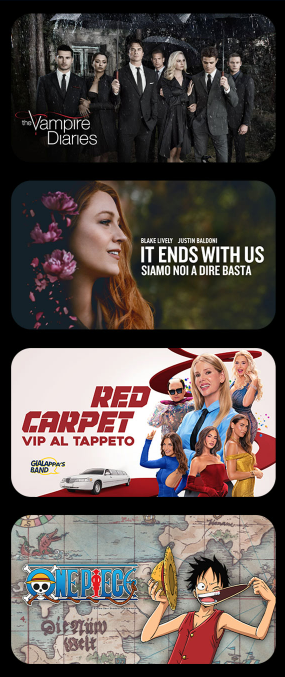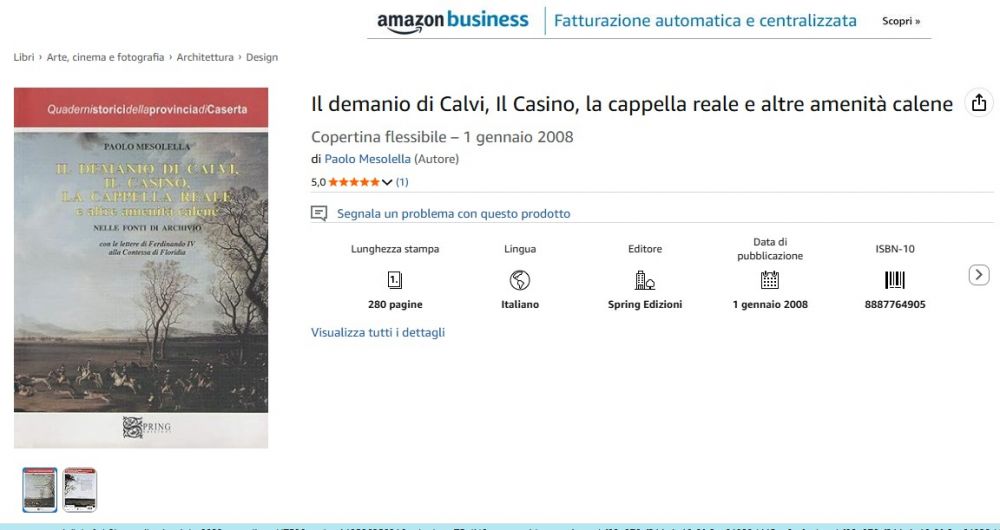Il Demanio di Calvi e la chiesetta borbonica.
29-07-2025 11:02 - Storia
di Salvatore Piccolo*
Torna d’attualità la vicenda storica del Demanio di Calvi, per buona parte ricadente nel territorio comunale di Sparanise. Il dibattito è incentrato sulla necessità di intervenire con urgenza sulla chiesetta borbonica che versa in condizioni precarie: può crollare da un momento all’altro. Sotto il profilo storico, non tutti conoscono le vicende di storia locale (fatto emerso proprio in occasione dell'allarme lanciato per il crollo), è opportuno ricordare l’importante lavoro fatto da Paolo Mesolella (Preside dell’istituto d’istruzione superiore Foscolo) Il demanio di Calvi, Il Casino, La cappella reale e altre amenità calene- Spring Edizioni, 2008. Partendo dal libro di Mesolella, dal quale abbiamo tratto diverse importanti fonti, ci permettiamo sintetizzare la vicenda rimandando alla lettura del testo indicato per i necessari approfondimenti.
I borboni già dal grande Carlo III, il fondatore della dinastia duosiciliana, avevano messo gli occhi sul Demanio di Calvi. Un antico bene collettivo, situato nelle campagne calene, sul quale insisteva un bosco ceduo e le popolazioni di Calvi e Sparanise avevano il diritto di fare legna. Quando durante l’occupazione francese, nell’ambito della riforma fiscale e amministrativa voluta da Giuseppe Napoleone (che portò anche all’istituzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), si stabilì che Sparanise divenisse municipio, staccandosi da Calvi, il Demanio (che significa bene inalienabile vincolato a uso collettivo) fu per la maggior parte attribuito a Sparanise, ma l'uso di una parte del bosco era anche a beneficio di a Calvi.
I borboni già dal grande Carlo III, il fondatore della dinastia duosiciliana, avevano messo gli occhi sul Demanio di Calvi. Un antico bene collettivo, situato nelle campagne calene, sul quale insisteva un bosco ceduo e le popolazioni di Calvi e Sparanise avevano il diritto di fare legna. Quando durante l’occupazione francese, nell’ambito della riforma fiscale e amministrativa voluta da Giuseppe Napoleone (che portò anche all’istituzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), si stabilì che Sparanise divenisse municipio, staccandosi da Calvi, il Demanio (che significa bene inalienabile vincolato a uso collettivo) fu per la maggior parte attribuito a Sparanise, ma l'uso di una parte del bosco era anche a beneficio di a Calvi.
Carlo III aveva deciso che in quei boschi risultava piacevole fare delle periodiche battute di caccia e per questo aveva ottenuto collaborazione dagli amministratori locali per popolare la zona di selvaggina. L’illuminato monarca decise allora di affittare i terreni del bosco, prendendoli in affitto dal barone Luigi Zona (è documentato un primo contratto durato sino al 18/10/1779 poi prorogato di altri 10 anni) che in realtà poteva vantare la proprietà dei terreni con esclusione del bosco. Poi arrivò, nel 1799, la rivoluzione napoletana che aveva tra i protagonisti i figli del barone di Montanaro, Leopoldo e Stanislao de Renzis, un casato quello dei De Renzis che avevano una grande influenza su Sparanise, che è stato storicamente un territorio mai infeudato. Nella repubblica uscita dalla effimera stagione rivoluzionaria i due aristocratici ebbero il ruolo di ministro dell’interno (Stanislao) e della guerra (Leopoldo). La repubblica partenopea fu abbattuta dai Borboni con l’esercito sanfedista agli ordini del cardinale Fabrizio Ruffolo e Leopoldo fu impiccato in piazza Mercato a Napoli il 12 dicembre del 1799. Poco dopo il regno di Napoli passo ai francesi di Napoleone.
Con la restaurazione dei Borboni, dopo l’occupazione francese e il congresso di Vienna, la zona adiacente i possedimenti del barone di Montanaro non godeva di protezione reale. Anzi i De Renzis erano invisi alla dinastia regnate. Forse anche per questo Ferdinando II decise di inserire il Demanio tra i beni reali e, forzando la mano, istituì sulla zona un maggiorato per i suoi figli maschi: con decreto regio del 12 gennaio 1832 il Demanio è assegnato in eredità ai figli senza badare che il territorio rappresentava un demanio al servizio dei Municipi di Sparanise e Calvi.
Sul possedimento così rivendicato fu imposto anche un presidio armato militare con l’esercito borbonico collegato alla guarnigione, comandata da un ufficiale, di stanza nella fabbrica delle armi bianche, opificio militare dell’esercito borbonico. Il ee per sopprimere i diritti e le proteste dei locali che spesso si recavano per il legname nel bosco con o senza autorizzazione, incurante delle formali proteste dei due Municipi, ordinò il taglio del bosco, il dissodamento del terreno, eliminando di fatto le pretese “di fare legna”. Del bosco oggi non vi è più traccia.
Il Demanio di Calvi in quegli anni divenne un sito di caccia, ad uso esclusivo dei reali, che vi costruirono un Casino Reale (piccolo caseggiato) con il pianterreno destinato ai contadini con il compito di custodire e curare il fabbricato (una specie di moderni fattori), mentre il primo piano era riservato al Re e ai cortigiani ed essere sempre pronto “all’uso” di fianco al caseggiato l'insedimaneto si completava anche con una chiesetta (che è quella oggi a rischio crollo) ed un piccolo fabbricato adiacente a servizio dei chierici. Il caseggiato collegato alla chiesetta durante l'ultima guerra è stato anche utilizzato come scuola per i bambini sfollati nella campagne del Demanio.
Il Demanio di Calvi in quegli anni divenne un sito di caccia, ad uso esclusivo dei reali, che vi costruirono un Casino Reale (piccolo caseggiato) con il pianterreno destinato ai contadini con il compito di custodire e curare il fabbricato (una specie di moderni fattori), mentre il primo piano era riservato al Re e ai cortigiani ed essere sempre pronto “all’uso” di fianco al caseggiato l'insedimaneto si completava anche con una chiesetta (che è quella oggi a rischio crollo) ed un piccolo fabbricato adiacente a servizio dei chierici. Il caseggiato collegato alla chiesetta durante l'ultima guerra è stato anche utilizzato come scuola per i bambini sfollati nella campagne del Demanio.
Nella metà del XIX era, però, difficile contrastare una decisione del Re e gli abitanti fecero di necessità virtù così che, quando il sovrano arrivava per la caccia, almeno una volta all’anno, gli abitanti potevano incontrarlo e rivolgergli suppliche che in genere venivano accolte proprio perché si voleva evitare che gli abitanti della zona si rivolgessero al baronato locale, inviso alla dinastia regnante per i fatti del 1799. Non va dimenticato che Sparanise è il luogo dove si scatenò la scintilla che portò alla rivolta dei lazzaroni e poi alla rivoluzione napoletana. Qui fu sottoscritto l’armistizio di Sparanise, da considerarsi l’atto scatenante dei moti rivoluzionari e non è un caso.
Nell'aula consiliare del Comune di Sparanise, le amministrazioni degli anni "buoni" apposero una lapide commemorativa ancora presente.
Solo con la caduta dei Borbone, i Municipi di Sparanise e di Calvi reclamarono il possesso del Demanio, supplicando inutilmente anche il re Savoia che pure avevano sostenuto nella “vicenda garibaldina” del 1860. Annibale Ranucci, borghese sindaco di Sparanise, aveva aiutato Garibaldi senza timori contro i Borboni. Ma i Savoia in realtà avevano interesse a tenere i beni nel patrimonio reale onde tenere la zona per sé.
Ranucci già prima della formale dichiarazione dell’unità d’Italia, il 23 dicembre 1860 aveva inoltrato a Vittorio Emanuele di Savoia una formale istanza
Solo con la caduta dei Borbone, i Municipi di Sparanise e di Calvi reclamarono il possesso del Demanio, supplicando inutilmente anche il re Savoia che pure avevano sostenuto nella “vicenda garibaldina” del 1860. Annibale Ranucci, borghese sindaco di Sparanise, aveva aiutato Garibaldi senza timori contro i Borboni. Ma i Savoia in realtà avevano interesse a tenere i beni nel patrimonio reale onde tenere la zona per sé.
Ranucci già prima della formale dichiarazione dell’unità d’Italia, il 23 dicembre 1860 aveva inoltrato a Vittorio Emanuele di Savoia una formale istanza
“L’anno 1860, il giorno 23 dicembre nella camera decurionale di Sparanise, riunitosi il decurionato nel numero di membri prescritti dalla legge, sotto la presidenza del sindaco Signor Annibale Ranucci ed in persona dei decurioni D. Giulio Ricca, D. Ambrogio Leardi, D. Carlo Leardi, D. Girolamo Rossone, D. Carlo Mesolella, D. Tommaso Compagnone, D. Pietro Fusco, D. Luigi Grande, D. Gaetano Ricca, ad oggetto di delibera della devoluzione del dominio utile del Demanio di Sparanise e Calvi, censito con istrumento del 1791 a Ferdinando IV, visto il detto istrumento del 28 settembre 1791 nonché l’atto parlamentare del 14 marzo 1790 fatto dalle città di Calvi e Sparanise, confidando che la censuazione di detto Demanio fatto dai due Comuni a favore di esso Ferdinando IV, ripugna con la volontà e gli interessi di essi Comuni[…]”.
Alla richiesta aveva aderito anche il sindaco di Calvi, Demetrio Zona, con analoga istanza, con la quale i due Municipi chiedevano al nuovo sovrano di intercedere con il governatore di Terra di Lavoro per ottenere indietro il Demanio e ristabilire l’uso civico. Di fronte al silenzio fu necessario avviare una causa affidata a due avvocati Saverio Correra e Domenico Di Roberto, la vicenda è documentata in un libello Per Calvi e Sparanise contro Demanio e Casa Reale, pubblicato nel 1888 da Francesco Saverio Correra e Domenico Di Roberto, e conservato nel Museo Campano di Capua.
La causa andò per le lunghe nonostante vari tentativi di mediazione. Nel 1919 il re d’Italia rinunciò "al dominio utile" su alcuni beni, tra cui l’ex tenuta borbonica (il casino e la chiesa). I terreni però anziché tornare ai Municipi furono ceduti dalla real casa all’Opera Nazionale Combattenti con l’obbligo per quest’ultima istituzione di versare delle rate di canone, mai accettate sia da Calvi che da Sparanise che continuarono a rivendicare il diritto di riavere il Demanio, soprattutto per evitarne la decadenza. Durante il fascismo l'Opera nazionale divise i terreni, parcellizzati e bonificati dal Duce, tra alcuni gerarchi.
La causa andò per le lunghe nonostante vari tentativi di mediazione. Nel 1919 il re d’Italia rinunciò "al dominio utile" su alcuni beni, tra cui l’ex tenuta borbonica (il casino e la chiesa). I terreni però anziché tornare ai Municipi furono ceduti dalla real casa all’Opera Nazionale Combattenti con l’obbligo per quest’ultima istituzione di versare delle rate di canone, mai accettate sia da Calvi che da Sparanise che continuarono a rivendicare il diritto di riavere il Demanio, soprattutto per evitarne la decadenza. Durante il fascismo l'Opera nazionale divise i terreni, parcellizzati e bonificati dal Duce, tra alcuni gerarchi.
* avvocato cassazionista, cultore di storia locale